

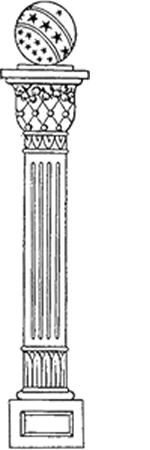
HOME
Questo è un Sito con nome e cognome
Perchè questo Sito?
Lettere Aperte di Gioele Magaldi (dal 2008)
Tutti i Video-Audio di YOU TUBE con Gioele Magaldi
Lista "Grande Oriente Democratico": Programma e iniziative
Proposte di Riforma Costituzionale nel G.O.I.
La Massoneria nel XXI secolo: sfide e prospettive
Proposte e Battaglie culturali degne di Liberi Muratori
In Memoria di Ivan Mosca, Franco Cuomo, Italo Libri
Via Iniziatica ed Esoterismo: Teorie e Pratiche
Documenti e Rassegna Stampa
Comunicazioni dei lettori/visitatori
Editoriali di Gioele Magaldi (dal 2010)
ORFANI del SACRIFICIO
di Gionata Agisti
“Chi non prende la sua croce su di sé e mi segue” diceva il maestro, come può sperare di entrare nel Regno dei Cieli? La croce, il crogiolo direbbero i saggi, da cui deve sbocciare la rosa mistica, la rosa della rinascita, il corpo glorioso del Cristo risorto. Come suona invece priva di poesia l’interpretazione letterale delle parole del maestro, per cui questa croce altro non sarebbe che il simbolo delle proprie fatiche, delle proprie sofferenze, da sopportare con rassegnato spirito di sacrificio, a immagine e somiglianza dei dolori patiti da Gesù di Nazareth; come a immagine e somiglianza dell’Altissimo l’uomo è stato pensato all’alba dei tempi.
Sacrificio, parola oggi perduta, perché perduto ne è il senso più autentico, etimologico: da consacrazione della propria intima interiorità - raggiungibile attraverso una suprema tensione volitiva, in grado di spezzare il guscio angusto del mondo conosciuto dai sensi - a sopportazione passiva dei capricci del destino, da viversi ben rintanati nell’involucro protettivo dei propri ristretti orizzonti; seme destinato a non maturare mai.
Il seme però deve farlo, se vuole dare buon frutto e, per maturare, deve inoltrarsi nelle viscere della terra, dove inizierà il suo personale calvario, dal quale uscirà inevitabilmente trasformato: novella pianta, verde e fresca, pronta a un nuovo inizio, quello vero, perché scaturito dal crogiolo della croce, che va amata, sì, ma non idolatrata dopo essere stata ridotta a feticcio.
Si sorvola troppo sulle parole di san Paolo, nella Lettera ai Galati: “Sono stato crocifisso con Cristo”; in questo passo c’è tutto il senso di che cosa sia la vera croce: non un legno, la cui importanza è da riconoscersi unicamente come simbolo - di cui il Cristo si servì per offrire la sua vita ad esempio - ma la propria anima, calata in un contesto unico e diverso per ognuno di noi, che va esplorata e osservata, per poi essere domata, perché è nel suo seno materno che è nascosto l’unico vero seme, un fanciullo, se preferite - la legge dell’analogia permette innumerevoli accostamenti – il puer sacro che, solo, detiene la conoscenza di noi stessi. “Lasciate che i bambini vengano a me e non impediteglielo, perché Dio dà il suo regno a quelli che sono come loro.” Il Latte della Vergine è l’unica bevanda che può dissetare l’uomo. Chi ha sete sarà dissetato.
Peter scelse da fanciullo la sua strada, non aspettò nemmeno la soglia della pubertà. Lui, a cui non erano state date da bere le acque di Lete e che della sua anima ricordava l’origine e la meta, sapeva che non ci sarebbe stato nessuno a fermarlo in tempo ai confini dell’adolescenza e che una volta varcata quella porta avrebbe dimenticato ogni cosa; tanto fragile è la condizione divina della prima infanzia che, proprio come una parola fu alla genesi del tutto, una parola può essere sufficiente a porle fine.
Fu per non cadere in tentazione, per non essere sedotto dal verbo velenoso, come il morso di una serpe acquattata nell’erba, che egli se ne volò via, come narra Barrie, verso i boschi, verso quell’isola protetta dallo sguardo profano di chi non ha occhi per vedere e orecchie per udire; quello stesso luogo in cui Adamo ed Eva, fattisi adulti, non poterono più restare, divenuti incapaci di comprenderne il linguaggio. Chi si venisse mai a trovare nella condizione di essere escluso dal gioco dei bimbi e ne assaporasse il terribile senso di angoscia non sarebbe così lontano da quella prima, fatale esperienza. In un attimo ricorderebbe: la vergogna di non aver saputo riconoscere la propria natura di fronte alla prima prova e di aver proiettato al di fuori ciò che di sé non aveva saputo accettare; allora, passato e presente in lui si confonderebbero, come la veglia e il sonno, ed egli camminerebbe sulla via dell’istante, dimora della verità che mai tentenna.
Stretta è la via, come la cruna di un ago, tanto sottile che solo chi sappia viaggiare leggero può sperare di attraversarla. Per questo motivo, i poveri e i mendicanti dello Spirito saranno più agevolati nel cammino.
Ci sono però due tipi di povertà: una povertà consapevole e una povertà inconsapevole. Solo la prima ci mette nella condizione utile per il risveglio. Chi infatti non sa di essere povero neppure sente il bisogno di rimediare al suo stato di necessità, cercando il nutrimento che solo può liberarlo o almeno dargli sollievo.
C’è poi chi si scoraggia dal mettersi in cammino o, una volta intrapresa la via, la abbandona, spaventato da una meta che si convince essere troppo distante per le sue forze. Ma non esiste qualcosa che possa definirsi come una meta prestabilita, perché ogni scopo prefissato non è che un limite che ci può vincolare, distogliendo la nostra attenzione dal presente, dall’attimo, l’unico sicuro punto di riferimento per la lunga traversata nella foresta dei simboli. Ecco perché ciò che conta è il viaggio, non il punto d’arrivo; ognuno potrà raggiungere se stesso, chiunque egli sia, e questa è l’unica cosa che conta.
Il Matto, provvisto solo della sua bisaccia, è colui che ha abbandonato il sentiero sicuro - che attraversa ma non si inoltra nel bosco - per scoprire quante diramazioni si presentano ai lati del tracciato; sempre che trovi in sé il coraggio di scoprire quale di questi condurrà lui, e lui solo, al centro della selva.
Ma Peter ebbe la fortuna di poter scegliere già da piccolo; noi, invece, per diventare come lui, siamo costretti a passare attraverso il varco della conoscenza di Pan. Pan, il Tutto, l’Onnipresente eppure il Celato, proprio come celato è il cielo, il Regno dei cieli. Occorre attraversare il terrore panico, saggiare lo spavento rigeneratore, la sensazione di comunione col tutto, che può annichilire l’imprudente ma illuminare l’audace, che si lascia guidare nel bosco, nel labirinto dell’oscurità, dal filo di Arianna, la grande tessitrice che vela o rivela.
Al termine del viaggio, nel ventre oscuro di una grotta, troveremo una mangiatoia, in cui giace un bimbo che chiede di essere riconosciuto. La luce fioca che lo circonda non lo permetterà facilmente ma quando saremo accanto a lui allora vedremo il suo volto e capiremo. Lui solo sarà d’ora in poi la nostra unica legge, perché lui solo conosce cosa è giusto o sbagliato per ognuno di noi; lui è il signore del bene e del male.
Innumerevoli sono le strade che conducono a Dio, innumerevoli quanto gli uomini e le donne di questo nostro mondo. “Il mio giogo è leggero”, perché è adatto a me e a me solo si addice. Chi comprende nel suo intimo questa verità non farà davvero fatica a rispettare l’antico precetto: “Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te stesso”, e l’altro, ancora più nobile: “Fa’ agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te stesso.” L’egoismo e l’invidia non sono del resto che frutto dell’insoddisfazione, a cui spinge una vita omologata, costretta entro solchi da qualcun altro tracciati, privando così gli esseri umani del loro unico tesoro, la loro unicità, la loro propria croce.
E ogni diramazione si inoltra sempre in un bosco, luogo d’incontri e di incontri fondamentali: quelli con gli animali. Strani compagni di viaggio questi esseri, che percorrono la nostra stessa via con fare discreto, restandone ai margini. Occorre fatica e pazienza per ottenere la fiducia di un animale, per addomesticare un gatto selvatico, ad esempio; occorre saper entrare nel suo mondo, gradatamente, proprio come accade con i simboli, che chiedono di essere penetrati con intuizione e sensibilità, perché la conoscenza della loro natura sia piena e non soltanto superficiale. Perché l’esterno sia una cosa sola con la nostra interiorità.
Gli animali sono come i simboli. Lo sapevano bene i Bimbi perduti, alla corte di Peter, che con le loro pelli si vestivano, come sciamani danzanti sul confine dei mondi. Perché i simboli possano essere compresi, perché possano aprire i nostri occhi al loro linguaggio nascosto, richiedono umiltà e la messa in discussione delle nostre convinzioni illusorie, depositate dalla corrente del tempo.
Nella natura che ci è madre risiede il segreto della nostra esistenza e là dove la natura è incontaminata gli uomini hanno da sempre cercato l’illuminazione, in un deserto o nella più lussureggiante delle foreste, ovunque si possa essere in contatto con la forza primigenia che custodisce il nostro io più autentico, come una madre amorevole culla il proprio bimbo, ancora ignaro delle potenzialità che dormono con lui il sonno dell’intelletto e che sole potrebbero condurlo là dove la sua essenza lo reclama, al centro della sua croce. “Vegliate, perché non sapete quando il padrone ritornerà”.
È per fare la conoscenza autentica degli animali, archetipi dei diversi aspetti della sua natura, che l’uomo si spinge nel loro regno, regolato dalla Madre, la Signora degli Animali. Lei, che ha formato ogni cosa vivente, visibile o invisibile, conserva nel suo grembo ogni carattere, ogni singola parte dispersa del Dio che ha dato vita al tutto, unendosi a lei nell’amplesso sacrificale originario; così che non vi è nulla in questo mondo che non possa ricondurre a Lui. Egli è Orfeo, fatto a brani dalle Baccanti; è Dioniso, smembrato dai Titani ed è Osiride, mutilato da Seth. Il compito di rintracciare ogni componente dispersa all’esterno di noi e riportare così alla vita il Padre nel Figlio dentro di noi è affidato dalla Tradizione alla sua sorella e sposa Iside, la Vedova, i cui orfani sono chiamati a continuare quel lavoro, quel rito questa volta restauratore.
Questa è la vocazione dell’essere umano, chiamato in modi diversi a morire all’egoismo, non inteso in senso morale ma come cieca fiducia nella propria individualità e nella propria coscienza che, figlie del tempo, sono soggette alla legge del mutamento, del destino. Anche la tunica del Cristo, cucita in un solo pezzo, fu divisa al momento del supremo sacrificio da titanici soldati, che se ne giocarono le parti ai dadi; quei dadi simbolo del caso, del destino appunto, da cui troppo spesso ci si lascia guidare, senza mai mettere in discussione la realtà e, in ultima analisi, noi stessi, che della realtà o dell’illusione siamo in ogni momento gli artefici.
Per realizzare la nostra missione restauratrice, abbiamo a disposizione degli strumenti: i simboli, canale tra l’illusione esteriore e la realtà interiore. Chi deciderà, con il loro supporto, di compiere questa azione sacra su di sé, osando fare a meno della maschera che oscura il vero volto, scoprirà se stesso come riflesso del Padre. Questo è possibile perché, anche se ciascuno di noi è solo una delle parti disperse del tutto, ognuna di queste fiamme diffonde la stessa e identica luce che le ha generate; è così che solamente nella differenza si può manifestare l’unica verità. Ma l’operazione è delicata: la maschera è stratificata e noi stessi l’abbiamo modellata con cura, fino a innamorarci della sua forma, per nascondere sempre di più la terribile vergogna sperimentata di fronte alla prima, fatale prova che la vita ci offrì.Nel cuore della foresta, custodito dagli animali, c’è un albero che svetta sopra tutti gli altri; ogni forma vivente è nata e si è sviluppata attorno al suo tronco: la selva che lo circonda e, mano a mano che ci si allontana, il dominio di Caino, degli uomini che hanno deciso di privarsi della sua ombra, preferendo riprodurre foreste artificiali pur di esserne i padroni. Ma la linfa non scorre nelle loro dimore e chi voglia tornare a dissetarsene, per poter danzare di nuovo attorno al primo albero, deve per forza ferire la dura corteccia e penetrare nel suo seno, dove la luce della ragione non abbaglia ancora la vista dell’uomo e l’ombra rende confuse e indistinte le cose, che allora si scorgeranno simili tra loro. Qui egli rimarrà finché i suoi occhi non si saranno abituati all’oscurità, poi attenderà che sia notte prima di uscire dal grembo in cui si era fatto strada con la forza e veglierà ai piedi dell’albero, aspettando l’alba e il sole di cui ora scorgerà la vera luce.
C’è un periodo della sua vita, in cui ogni essere umano conosce solo attraverso l’immaginazione; un periodo sfortunatamente troppo breve. Gli occhi sono gli strumenti primi che un bimbo possiede per entrare in contatto con la realtà ed è attraverso di loro che il mondo penetra con prepotenza e senza filtri all’interno della sua anima, suggerendogli concetti semplici e fondamentali che, se la sua immaginazione venisse correttamente educata, potrebbero in seguito rivelarsi come porte spalancate verso il trascendente.
Come si può descrivere l’emozione di un bimbo che per la prima volta fa la conoscenza di una pianta? Chi è in grado di ricordarla se non la rivive da sé, se con tutto se stesso non decide di lacerare il velo che ha ricoperto il suo sguardo invecchiato anzitempo, puro e innocente com’era?
Di fronte a una pianta incontrata per la prima volta non saranno certo i dettagli o il desiderio di conoscerne il funzionamento interno ad attirare la nostra attenzione. Non saranno piuttosto l’idea di altezza, di forza, di imperturbata quiete a colpire la nostra immaginazione e, perché no, a suggerirci un esempio da imitare?
Prima viene l’immaginazione, poi la ragione. Ma la ragione non si accontenta dello spazio che la natura le ha affidato; non le basta essere di complemento alla sorella, reclama più spazio e, come un tiranno, pretende che sia quest’ultima a rinunciare al suo ruolo e alla sua funzione, per inchinarsi al volere del più forte. Perché l’immaginazione è fragile e delicata, come il profumo dei fiori che annunciano la primavera, disperso al primo vento; non ha dalla sua alleati e seguaci numerosi, pronti a violare la mente del primo uomo, inculcandogli la vergogna per il proprio attardarsi in un mondo che ha scelto nella fretta il suo nume tutelare.
Per comunicazioni, scrivete a: info@grandeoriente-democratico.com